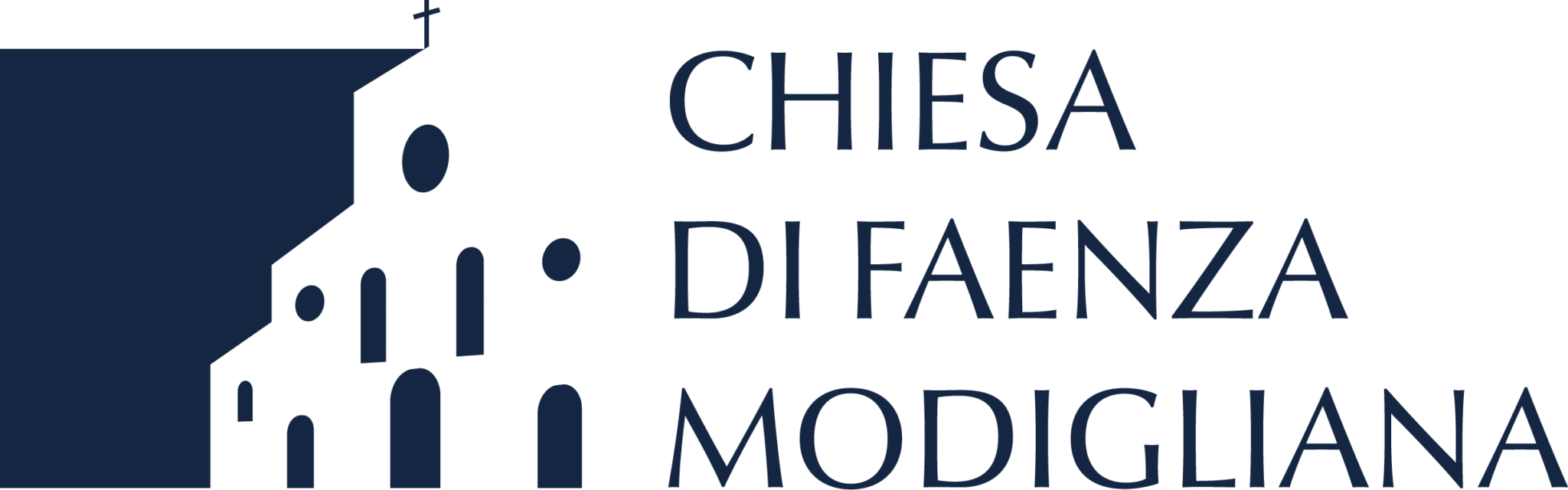Don Antonio Torresin
Per non perdere la grazia degli inizi
La grazia degli inizi
Esiste una grazia degli inizi, alla quale è bene sempre ritornare, anche se non è così semplice. L’inizio ci precede, l’origine – della vita, della fede, della vocazione, del ministero – è un segreto custodito nel cuore di Dio. Proprio per questo “tornare agli inizi” è necessario e benefico, è ritornare e ritrovare quella sorgente inesauribile della vita, della fede, della vocazione. Già il fatto di mettere in relazione vita – fede – vocazione – ministero, allude al fatto che l’inizio non mai un evento puntuale e concluso, piuttosto un movimento che accade e ri-accade nella nostra vita. Non basta nascere, occorre ri-nascere, e l’evento della nascita biologica, l’inizio della vita, non è che una promessa che chiede di essere ripresa in una rinascita nello Spirito, dall’alto (Gv 3).
Potremmo provare a mettere a fuoco due aspetti della “grazia degli inizio”: la vocazione e l’entrata nel ministero (che è poi il prender forma della vocazione iniziale).
La scena originaria
Prendiamo lo spunto dal primo capitolo del Vangelo di Marco:
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”. 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!”. 25E Gesù gli ordinò severamente: “Taci! Esci da lui!”. 26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!”. 28La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. (Mc 1,16-28)
Passando: la fede e gli incontri casuali della vita.
C’è un tratto che potremmo chiamare “casuale” (il caso o la grazia?) della chiamata: il Maestro è passato proprio da quel lato del lago e non un altro, in quel giorno preciso e non un altro, e si rivolge a quegli uomini che incontra, proprio a loro e non ad altri. Perché? Nelle circostanze della vita accade qualcosa che sembra casuale, che diventa principio di tutto: «“Dio passa”, la gloria “passa”, e ancora “si passa”» (Levinas). È la memoria di un incontro, il ricordo esatto di un avvenimento accaduto che lascia intravvedere tutta la profondità che si cela negli incontri della vita. Spesso nella catechesi e nella riflessione sulla fede, mettiamo l’enfasi sulla decisione (la fede è una “opzione fondamentale” si diceva negli anni 70, una decisione della libertà). Certo, è vero, ma questa decisione è resa possibile, anzi propriamente suscitata, da un incontro che è del tutto indisponibile e imprevedibile. C’è qualcosa che ci precede e che non è possibile pensare di controllare e prevedere. Neppure le qualità e i talenti dei chiamati giustificano il fatto che il Signore si sia rivolto proprio a loro. I criteri per cui il Maestro chiama non sono riconducibili a meriti, qualità, predisposizioni. In tutte le chiamate nella Scrittura questo è un dato evidente: il Signore chiama a sé quelli che “egli volle” (Mc 3) e perché li vuole lui, e tanto basta. Al più la scelta del Signore si rivolge inaspettatamente proprio a uomini e donne improbabili, come ha chiamato il popolo di Israele non perché fosse il popolo migliore, anzi era il più piccolo e insignificante. In realtà questo dato è decisivo perché custodisce appunto la “grazia” degli inizi: l’inizio è una grazia, un dono, un atto d’amore che ci precede, senza premesse né condizioni. Dovremmo tenere sempre presente questa gratuità e incondizionatezza della scelta: “non so perché il Signore ha scelto proprio me, perché ha voluto coinvolgere in questa storia proprio me che sono un peccatore, per nulla migliore degli altri uomini; anzi, potrei dire che se non mi avesse chiamato mi sarei perduto”.
Venite dietro a me (dimensione cristologica)
Un secondo tratto della grazia degli inizi è la centralità della figura di Gesù. L’inizio della fede è dato da una attrazione irresistibile. Qualcosa che ha a che fare con l’umanità di Gesù, il suo modo particolare di parlare e di agire, il suo passo e il suo sguardo. Inizia una postura che sarà fondamentale: “stare dietro”. E quando Pietro vorrà mettersi avanti e indicare a Gesù dove andare o non andare, verrà ferocemente redarguito: resta dietro a me, Satana! Andare dietro, seguire, mettere le proprie orme sulle sue, seguire le sue tracce, ecco il tratto cristologico della fede del discepolo. La sequela non è l’adesione ad un sistema di valori, ad una dottrina di verità, ma la riposta alla testimonianza di vita che traspare dalla vita di Gesù, dal suo “stile”, dalla sua “santità ospitale” (Theobald). Per questo chiede una relazione interpersonale, prima ancora di una adesione intellettuale: non si tratta di credere in determinate verità, dogmi, sistemi di valori; si tratta di riconoscere l’imperativo iscritto in quell’incontro. Riconoscere che quel Maestro è capace di accendere il desiderio del nostro cuore, perché intimo a noi stessi, come dice Agostino: tu eri in me e io ti cercavo fuori di me.
Pescatori di uomini (continuità e discontinuità) dimensione antropologica
Anche il luogo dell’incontro ha un significato simbolico. “Lungo il mare di Galilea”: è il mare di Tiberiade o di Genesaret, a volte detto semplicemente il mare; qui Gesù incontra dei pescatori e li “assume” trasformando il loro lavoro. Si è molto discusso sul senso di questa immagine: pescatori. Quale è il mare? Che senso ha “pescare” gli uomini? Salvarli dalle acque? Attraversare il mare uscendone vivi? E’ difficile dirlo. Mentre nell’A.T. il lavoro dei profeti era efficacemente associato a quello del pastore (che raduna, nutre e pasce), qui abbiamo un altro mestiere, il pescatore. Di fatto essi metteranno la propria barca a disposizione del Maestro perché la sua Parola giunga a tutti e forse vuol dire semplicemente questo: egli trasforma ciò che sono, rendendo la loro “professionalità” a servizio del regno. Restano pescatori, ma nel loro pescare accade qualcosa d’altro, Dio stesso si annuncia. Il Maestro trasforma i suoi discepoli assumendo tutto ciò che essi sono. Nulla va perduto della propria personalità ma tutto va trasformato e in qualche modo lasciato: lasciare la casa, il lavoro, i fratelli, la famiglia, per ritrovare tutto questo “cento volte tanto”, in un modo nuovo.
Subito lo seguirono
Colpisce la perentorietà della risposta, che è conseguente alla gratuità della chiamata. Come in Abramo l’atto di fede consiste in un “eccomi”. Chiamata e risposta sono corrispettive, ma è la chiamata che suscita risposta, e nella risposta – eccomi – si rivela il carattere trasformativo della chiamata. «La chiamata di Gesù è una chiamata che viene dall’Altro in modo sorprendente affinché il soggetto assuma responsabilmente il proprio essere. La responsabilità, come la decisione, appare quindi senza padronanza rispetto alla chiamata. (…) Non a caso la decisione nel testo biblico si esprime attraverso l’imperativo “Eccomi!” (hinnèni, nella lingua ebraica) che sigla la sua natura di risposta, di adesione all’appello, di assunzione della responsabilità di fronte all’Altro. Gesù stesso, come scrive Kierkegaard, “non attende che qualcuno vada a lui; egli viene da sé, senza essere chiamato, perché è lui colui che chiama”. (…) È la chiamata del desiderio dell’Altro che mette in moto il desiderio del soggetto come risposta all’incontro con quella chiamata. Si tratta di un decentramento del proprio Io, di una separazione dalla condizione meramente auto-conservativa della vita, alla vita toccata dalla grazia, alla vita capace di generare frutto. È solo ex-sistendo, scrive a proposito Jullien, che “il soggetto può passare dal regime della psiché, dell’attaccamento al proprio essere vitale nel mondo, alla zoé, la vita “sovrabbondante” in quanto realmente eccedente la misura di questo mondo”» (Recalcati, La legge del desiderio, pp. 124-126).
Chiamati insieme. La dimensione ecclesiale della chiamata
Nella scena evangelica troviamo più personaggi che vengono chiamati: Simone e Andrea, poi Giacomo e Giovanni. Il Vangelo di Giovanni nel capitolo 1 racconta la chiamata come una catena di incontri che si succedono uno via l’altro. Se la chiamata e la risposta sono personali – nessuno può rispondere al posto di un altro, nessuno è chiamato da solo. Nella sua costruzione Marco, in seguito, riporta questa “associazione”, all’inizio, in questo dittico che mette insieme annuncio del Regno e chiamata dei discepoli come di un gruppo che viene a costituirsi. Le due cose stanno insieme: Gesù va a predicare e costituisce un gruppo di discepoli collaboratori diretti della sua missione. La missione è portatrice di collaborazione, perché questo è lo stile di Dio: egli non fa da solo, agisce attraendo e irradiando, coinvolgendo e assumendo l’opera dell’uomo nella propria. Là dove avanza la grande Via, nascono dei circoli di persone, si comunica e si diffonde un’attrazione, si stabiliscono nuovi legami di vita che strappano i vecchi legami e li riplasmano. Là dove appare un maestro, compaiono anche dei discepoli al plurale, come gruppo. Fin dall’inizio la chiamata ha una costitutiva dimensione ecclesiale. Si viene chiamata dalla chiesa e nella chiesa: sia perché l’incontro con Gesù passa attraverso l’incontro con discepoli e credenti che ne sono testimoni (in questo il racconto giovanneo è particolarmente preciso) sia perché la chiamata ci inserisce in una trama di relazioni senza la quale non prende forma il discepolato. È il passaggio da una chiamata personale a una risposta ecclesiale, dall’ “io” dell’Eccomi, al “noi” che riconosce di essere inserito in una rete più grande del singolo. «Se dovessimo mettere a fuoco la questione cruciale per noi ora, potremmo esprimerla così: da una vocazione percepita come “mia”, ad una chiamata vissuta come “nostra”. È la posta in gioco; l’itinerario che ci viene richiesto è di questa natura. A ben vedere si tratta dell’affacciarsi di una “logica antica” iscritta stabilmente nel cammino storico del popolo di Dio: un’avventura che parte in “solitaria” nei passi di libertà di una persona che viene imprevedibilmente visitata da Dio e diventa gradualmente cammino di molti, addirittura di un popolo intero» (F. Brovelli, in Presbiterio è comunione, p 110-111).
Entrare nella missione taumaturgica del Maestro (Gesù i discepoli e le folle)
La chiamata dei discepoli è subito seguita dal racconto del ministero taumaturgico di Gesù che si immerge nelle folle per mostrare con segni di bene l’avvento del regno. Il legame tra la chiamata e la missione (la stessa di Gesù) è evidente anche in un’altra scena dl vangelo di Marco, al capitolo 3, in un quadro sintetico della scena originaria del regno:
7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea 8e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. 11Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». 12Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. 14Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare 15con il potere di scacciare i demòni. 16Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 17poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; 18e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo 19e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Qui Marco descrive anche una sorta di “postura” delle relazioni che Gesù intesse tra sé, la folla e i discepoli. Da una parte egli non si sottrae alla pressione delle folle che lo cercano e si stringono a lui per cercare un contatto con la forza che sembra fuoriuscire dalla sua umanità; dall’altra non si lascia schiacciare, prendere (anche questo è un tema dell’intero capitolo) e per questo ha bisogno di porre una certa distanza tra sé e le folle. A questo servono i discepoli, che gli sono prossimi, proprio per agevolare la sua azione. Ad essi chiede di mettere a disposizione una piccola barca (il diminutivo utilizzato esprime tutta la fragilità di questo che sarà un simbolo straordinario della configurazione dei discepoli attorno al maestro). Occorre, infatti, una giusta distanza: né troppo lontani – perché Gesù non si sottrae mai ai bisogni delle folle – né troppo vicini – per non essere sequestrato da nessuno. È certo che Gesù non si è lasciato prendere dall’entusiasmo popolare. «Una grandezza di Gesù nella sua vita pubblica è che non ha seguito i suoi successi” (Marcel Légaut). Questo dice molto anche della “postura” dei discepoli: anche loro non possono né separarsi dalla folla – ad essa Gesù costantemente li riporta, come poi in 6,34-44) – né separarsi da Gesù, senza il quale non possono fare nulla. Gesù stesso, mentre parla alla gente, istruisce i discepoli e non agisce mai a favore delle folle, senza coinvolgere in qualche modo i suoi.
L’inizio del ministero
Proviamo ora a rileggere alcune delle dimensioni dell’inizio della vocazione, in quel momento particolare che è stato l’inizio del ministero. Un momento particolare nel quale si invera – diventa vero, più vero, vero in modo nuovo – l’inizio di una vocazione alla sequela. Non è l’unico momento in cui si “inizia”, meglio si viene iniziati: certo con la grazia sacramentale dell’ordinazione uno è già pienamente presbitero, ma insieme lo diventa nell’esercizio, nella storia concreta che plasma la sua umanità conformandola – certo, è anche possibile che invece nella storia si “deformi”…. – alla chiamata, alla grazia dell’inizio.
Mandati dove non avremmo mai immaginato
Un primo tratto che mi piace sottolineare è che – in genere – nessuno sceglie la propria destinazione. Dico “in genere” perché può esserci la tentazione di “predeterminare” il proprio percorso presbiteriale: non è raro e non è un bene! Ma in genere soprattutto all’inizio, la disposizione di chi comincia la propria vita da prete è quella di una disponibilità incondizionata. Non sappiamo prima dove saremo destinati, e spesso la destinazione sorprende le proprie aspettative. È un poco come per Abramo che è chiamato a partire per una terra che non conosce: così chi inizia il ministero è mandato dove non conosce, in una comunità che per lui è una terra nuova inesplorata. Proprio così prende forma una decisione, un “si”, un “eccomi” che ha il proprio fondamento su di un atto di fede e di affidamento. Non si decide se non perché qualcuno chiama e invia: “una decisione senza padronanza rispetto alla chiamata”. Parliamo della “prima” destinazione, ma non dovrebbe essere così per ogni destinazione? È vero che – giustamente – più si cresce nell’esperienza della pratica del ministero, più prendono forma competenze, attitudini, che entrano in gioco nelle future destinazioni. Accade allora che le ulteriori destinazioni siano anche l’esito di un dialogo tra le esigenze della chiesa e le attitudini del singolo. Ma non dovrebbe sempre rimanere questo tratto dell’inizio, ovvero il coraggio di partire per un luogo che non conosciamo, semplicemente fidandoci della chiamata che viene dall’Altro?
La sproporzione insuperabile
Un secondo tratto dell’inizio del ministero è la percezione di una sproporzione insuperabile. Lo esprime bene Salomone nella sua preghiera: «Ebbene io sono un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?» (1 Re, 3, 7-9). Ogni responsabilità che la chiesa e la vita ci affida è sempre superiore alle nostre forze e capacità: crederlo sarebbe presunzione pericolosa, averne paura sarebbe una forma di codardia, di cuore debole. Di che sproporzione si tratta? Anzitutto chi inizia non ha le competenze che servirebbero: anche la migliore delle preparazioni – e ho seri dubbi che il percorso formativo attuale sia in grado di essere all’altezza delle necessità odierne – non basterebbe a colmare la sproporzione. Più profondamente credo che si sperimenti una piccolezza della propria fede: chi siamo noi per essere chiamati ad accompagnare il cammino di fede di altri – perché di questo si tratta – quando la nostra stessa fede è poca cosa, fragile e claudicante? Serve una buona dose di umiltà per iniziare, serve fare i conti con la propria “poca fede”, come Matteo spesso parla della fede dei discepoli della loro ολιγοπιστια.
La sproporzione ha poi a che vedere con le forze che abbiamo, sia personali che come chiesa. Di per sé è strutturale come Gesù avverte quando invia i discepoli: “la messe è molta e gli operai sono pochi” (Mt 9,37). Ma sempre esiste la tentazione di azzerare la sproporzione, di confidare in mezzi potenti, risorse infinite. Sempre Gesù in quelle ammonizioni avverte di un altro contrasto: vi mando come “agnelli in mezzo a lupi”. Il rischio è di assumere uno stile mondano nell’esercizio del ministero.
Infine, la sproporzione è tra le intenzioni che animano chi inizia il ministero e le attese che spesso premono su di lui. Si parte con le migliori intenzioni di annunciare il Vangelo, di prendersi cura della fede, di costruire legami di comunità, ma poi ci si accorge che la gente chiede altro: un servizio sociale, la coltivazione di una religiosità che a volte non ha molto a che fare con il Vangelo, una aggregazione sociologica ecc. Se restiamo fermi sulle nostre intenzioni rischiamo di deludere, se inseguiamo le attese richiamo di tradire il mandato. Reggere questa sproporzione può essere frustrante.
Entrare nella storia di una comunità
Da ultimo vorrei sottolineare la dimensione ecclesiale dell’inizio del ministero. Siamo mandati da una Chiesa che ci precede, e inviati ad una Chiesa che ha una storia prima di noi e magari diversa dalla nostra. Non si inizia da zero, non siamo i primi e non saremo gli ultimi. Si tratta di entrare in una storia, di fare i conti con una tradizione – ma anche con delle semplici consuetudini – che a volte diventa semplicemente una inerzia: “si è sempre fatto così”. È molto difficile l’equilibrio tra il rispetto della storia di una comunità e il discernimento di passi nuovi che proprio l’arrivo di un nuovo prete potrebbe propiziare. Si corre il rischio di un eccessivo adattamento, di procedere per inerzia e ripetizione, o al contrario di pensare che tutto comincia con noi, tutto debba cambiare.
Ma soprattutto occorre fare i conti con le debolezze e gli scandali che sono presenti anche e proprio dentro la Chiesa. Ricordo un giovane prete che esprimeva la sua delusione così: “sono partito pensando di annunciare il Vangelo, e mi trovo a dover dirimere le beghe di sacristia; che gli uomini nel mondo siano chiusi in piccoli interessi personali di potere lo capisco, ma che questo accada anche nella parrocchia, mi scandalizza un poco”. Per non parlare della relazione tra preti: siamo ordinati per far parte di un presbiterio, ma l’esperienza concreta dalla fraternità presbiterale non è certo esente da ferite, e ferite che a volte fanno molto male. Sembra che oltre una certa enfasi sul presbiterio e sulla sinodalità, la percezione di molti preti sia quella di un certo isolamento che ferisce profondamente.
Entrare in una storia di comunità chiede una umile pazienza, la capacità di sopportare pesi che vengono da lontano, ma facendolo con leggerezza, trasformando i pesi in un “giogo” comune, da portare insieme, tra di noi e con il Signore, mite e umile di cuore. La fraternità può allora diventare un luogo di trasformazione, di creatività, cogliendo dove lo Spirito ci sta portando. Assumere una storia e viverne la trasfigurazione, come il Signore che nel mistero dell’incarnazione ha preso su di sé la nostra condizione umana per farne una storia di salvezza. Ma non è un’opera da fare da soli: è proprio stando dentro la storia di una comunità, dentro il “popolo santo di Dio” come lo chiamava Francesco, che possiamo scoprire le nuove cìvie che il Signore prepara per noi.
Domande per continuare
Ecco allora alcune semplici domande per raccogliere la “grazia degli inizi”:
La fede di un prete
Moioli richiamava spesso che il prete è anzitutto un uomo, un credente, chiamato al ministero. Uomo e credente: In che modo la fede ha plasmato la mia umanità?
Quali punti critici di conversione sono emersi (rigidità, fatiche e resistenze, momenti di crisi) che hanno messo alla prova la mia umanità? Quali attitudini sono cresciute (ascolto, sensibilità nelle relazioni, affetti, intuizioni….)?
Crescere nel ministero
Conservo ancora la gioia di essere prete? In che modo è diversa dalla gioia dell’inizio? Nei passaggi di ministero che cosa è cambiato nel mio modo di essere prete?